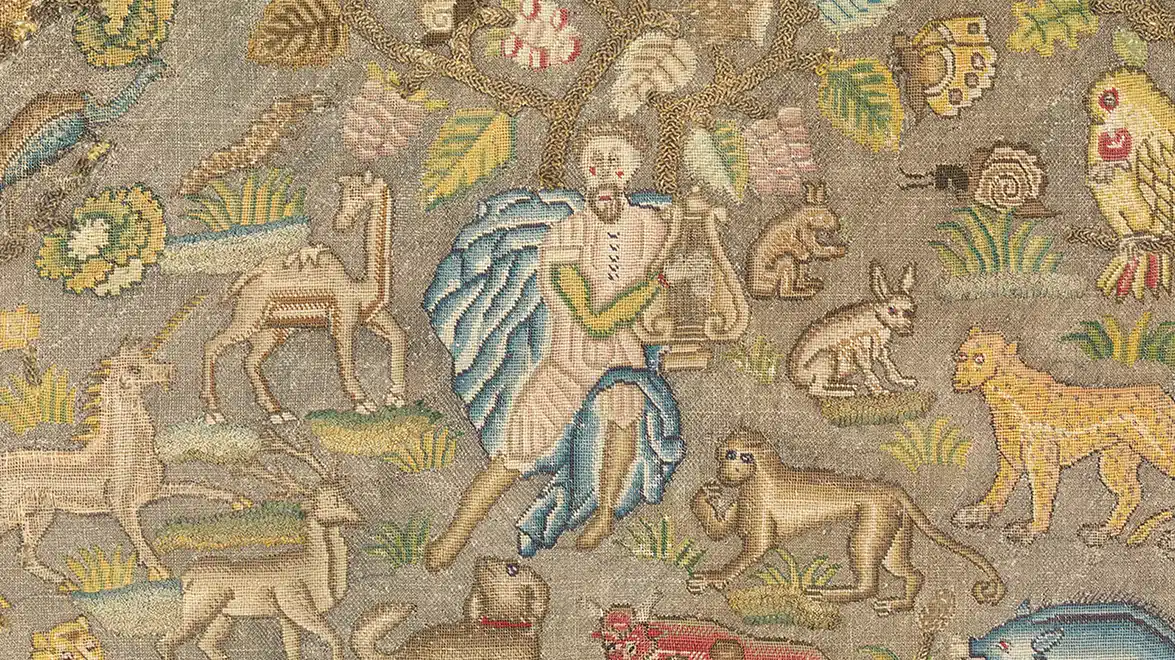Un percorso formativo cofinanziato dalla Commissione Europea (Modulo Jean Monnet ‘EuRheSHis’) e da un PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) propone di dare nuovo corso all’idea antica della retorica come fondamento della giustizia. Le tecniche della persuasione, che la cultura moderna ha spesso relegato tra gli attrezzi in disuso, possono essere oggi strumenti utili per costruire una società giusta e controllare criticamente il dibattito pubblico. Ce lo spiega il professor Federico Battaglia, titolare nel nostro ateneo della cattedra di Elementi di diritto romano e - appunto - di un nuovo insegnamento di Teoria e storia della retorica giuridica europea.
Oggi termini come “public speaking” o “debate” sono di uso corrente, ma la controversia, la dialettica e la retorica erano pane quotidiano nel mondo antico greco e romano. Come mai secondo lei c’è questo ritorno di moda di alcuni termini e perché ce ne eravamo allontanati?
Non so se la retorica sia tornata di moda: vero è che oggi stiamo cercando di reintrodurla ufficialmente nella nostra facoltà di Giurisprudenza, all’interno di un progetto pilota. È noto che la retorica ha subito negli ultimi due secoli una svalutazione progressiva: si è passati dal considerarla una materia altamente formativa all’oblio o al discredito di oggi.
La retorica classica, per come è stata studiata per secoli, abbracciava in effetti le diverse fasi di formazione del discorso, dall'ideazione e dalla scelta degli argomenti alla loro disposizione in un ordine logico, fino all’espressione verbale, alla memorizzazione e infine alla presentazione pubblica del discorso. Nel corso degli ultimi due secoli questa ricchezza di contenuti si è persa e la retorica si è ridotta al piano della scelta stilistica. Di più: la retorica stessa è stata identificata con la ricerca di uno stile ben preciso, quello ampolloso, ben rappresentato dalla caricatura del giurista parolaio che a volte ci è capitato di vedere al cinema.
La parola “vuota” è però il contrario della parola “piena” degli antichi, che intendevano costruire il discorso calibrando ogni singolo suono, per convincere dell’opportunità di una scelta politica, tessere le lodi di un personaggio pubblico o persuadere un organo giudicante. Si tratta perciò, oggi, non solo di “riaprire il discorso”, cioè di recuperare tutte le fasi della sua costruzione, ma anche di trasmettere l’idea che una coscienza retorica seria ha un impatto importante sulle nostre vite.
Però la separazione tra la tecnica del persuadere e l'elemento conoscitivo era già emersa nel mondo antico, con la critica ai sofisti da Socrate in avanti.
Infatti: la critica ai cosiddetti “sofisti” aveva suggerito ai filosofi antichi di governare la forza della parola, che poteva portare a distorsioni o manipolazioni, con briglie razionali ed etiche. Da un lato, per certificare l’attendibilità degli argomenti portati dall’oratore, furono importate nella retorica le procedure scrupolose della dialettica, a cui i filosofi affidavano la ricerca della verità. Dall’altro lato, si individuarono criteri (competenza, onestà, dedizione alla causa) per capire se dare credito all’oratore stesso. Anche questo è un tema che torna ad essere sentito ai nostri giorni, in cui abbondiamo di informazioni (prodotte o divulgate da esseri umani o, cosa nuova, da algoritmi), ma siamo spesso a corto di strumenti per misurarne l’affidabilità.
Quali sono stati i grandi antagonisti culturali che hanno finito per mettere un po’ nell’angolo la retorica rispetto alla centralità originale?
Chi si è occupato di questi temi ha riconosciuto alcuni ‘nemici della retorica’. Da un lato, il campo d’azione della retorica si è, come detto, via via ristretto all’area dell’espressione verbale (in particolare a quello famigerato delle ‘figure retoriche’, che sono alla base dell’idea di discorso enfatico). Dall’altro lato, varie ‘filosofie e poetiche della verità’, a partire dall’Ottocento, hanno visto nella cultura retorica un ostacolo alla oggettività ricerca scientifica o, per contro, alla ‘sincerità’ e ‘autenticità’ dell’artista.
Del resto, in campo giuridico l’Illuminismo ha cambiato le carte in tavola: il diritto è stato fatto coincidere sempre più con le norme, perdendo la dimensione discorsiva che nell’antichità era invece usuale. La nostra ambizione è proprio tornare a mettere a fuoco l’importanza della dimensione ‘narrativa’ della giustizia, che include quella ‘normativa’ ma non si limita ad essa.
In campo educativo ultimamente c’è stata una ripresa dell’uso del dibattito come metodo per l’acquisizione di conoscenza condivisa. Lei cosa ne pensa?
Già dal secondo dopoguerra si è cercata una risposta culturale ai dogmatismi e ai totalitarismi. In questo contesto, alla “morte della retorica” è seguita in effetti una sua lenta e ancora parziale rinascita, sebbene sotto etichette diverse. Tra l’idea (spesso fonte di intolleranza) che esista “una sola verità” e quella, sfiduciante, che “non ci sia alcuna verità”, il discorso persuasivo si è collocato nello spazio di mezzo: poter decidere, attraverso un confronto ragionato, quale direzione imboccare nelle proprie vite, è parso a molti la via più ragionevole per ricostruire un futuro dopo le grandi guerre mondiali. Qui entra in gioco il bagaglio di valori (su tutti, libertà e giustizia) che il discorso retorico porta con sé dall’antichità.
A questo proposito mi piace precisare che il nostro progetto non si ferma a chi frequenta l’Ateneo, ma mira a coinvolgere anche le professioni legali e la società civile. Ai corsi veri e propri si affiancano per esempio seminari in cui gli studenti universitari, con l’aiuto di un disegnatore, produrranno un fumetto sui contenuti del corso, da trasmettere agli studenti delle scuole superiori.
Senza questo coinvolgimento attivo, potremmo in fondo dire, la parola non è mai davvero “piena” come vorremmo, né generativa di giustizia come merita di essere.