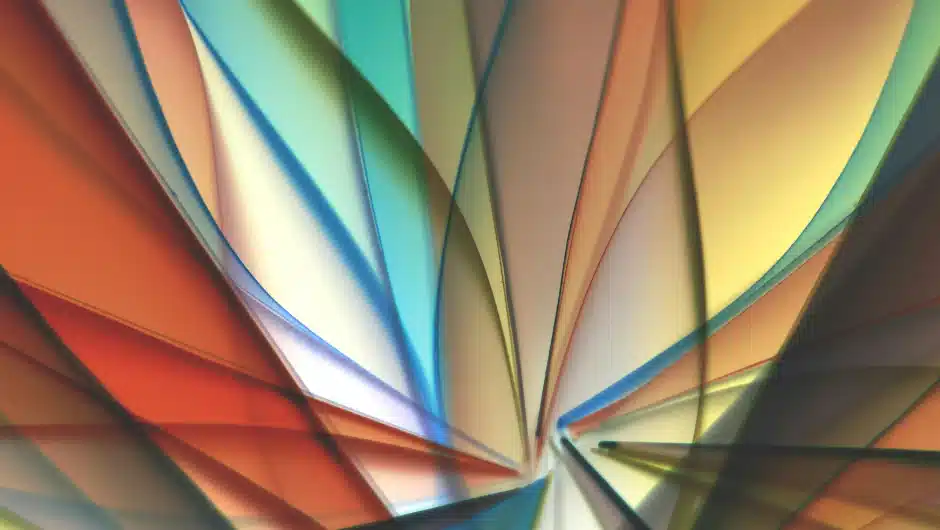Promossa dalla World Federation for Mental Health - WFMH - la Giornata mondiale della salute mentale è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 10 ottobre.
Con il talk “SÉnsazioni. Accenti e sfumature di ciò che accade nella nostra mente”, ideato da Viatris Italia in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, si vuole portare all’attenzione il tema della salute mentale con autenticità, empatia e competenza. L'evento, che si terrà venerdì 10 ottobre, rappresenta un’evoluzione del percorso della campagna Non Sono Solo, iniziativa di sensibilizzazione dedicata ai temi depressione, ansia e insonnia.
In attesa dell’appuntamento di domani, abbiamo approfondito alcuni temi con Ilaria Riboldi, medico psichiatra, con dottorato in Neuroscienze e attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, nel gruppo dei Professori Giuseppe Carrà e Francesco Bartoli.
Dal punto di vista psichiatrico, quali sono oggi le principali sfide che i giovani affrontano nel costruire la propria identità in un contesto sociale e digitale così esposto e competitivo?
L’adolescenza e la giovane età adulta richiedono di integrare autonomia, appartenenza e scopo in un sé coerente, ma l’ecosistema digitale, fondato su visibilità, metriche di approvazione e legami fragili, può rendere il compito più complicato. I social media e l'ambiente online creano una "vetrina mediatica" costante, amplificando la pressione al confronto con modelli spesso irrealistici o idealizzati. La necessità di esibirsi e di apparire può inoltre portare a una perdita di autenticità e a un senso di alienazione, complicando il naturale percorso adolescenziale di differenziazione. Ciò non significa demonizzare i social: è piuttosto necessario un approccio critico e consapevole per poterne trarre benefici, anche sul piano delle relazioni.
E dal punto di vista clinico e della ricerca, in che modo questa pressione sociale e digitale si riflette sul benessere mentale dei giovani e come si può intervenire?
Il veloce mutamento della società ha privato i giovani di riferimenti stabili, generando un senso di smarrimento e incertezza, che si concretizza in un profondo disagio esistenziale. Paradossalmente, in un mondo iper-connesso, emerge un profondo e diffuso vissuto di solitudine, come dimostrano i risultati della ricerca condotta dal gruppo, guidato dal Professor Giuseppe Carrà. La costante esposizione a vite altrui, apparentemente perfette e soddisfacenti, può far sentire i giovani inadeguati e isolati. La paura dell'esclusione (FOMO, Fear Of Missing Out) spinge a rimanere costantemente connessi, ma questa iper-presenza online spesso maschera un’assenza di connessioni significative, accentuando il sentimento di essere soli in mezzo a una folla virtuale.
A livello clinico, questa pressione si traduce in un aumento di disturbi d’ansia e disturbi depressivi, oltre a comportamenti disfunzionali, tra cui autolesionismo, alimentazione disregolata e dipendenze, spesso utilizzati come tentativi disfunzionali di coping.
La sfida per la pratica clinica e la ricerca è dunque duplice: da un lato, comprendere a fondo questi fenomeni emergenti e la vulnerabilità psichica dei giovani; dall'altro, sviluppare con urgenza interventi precoci e mirati che non si limitino a trattare il sintomo, ma che aiutino i giovani a costruire un pensiero critico e le risorse interiori necessarie a integrare un'identità complessa e autentica in un mondo in continua e velocissima trasformazione.
Quali sono, secondo la sua esperienza clinica e di ricerca, i campanelli d’allarme più spesso sottovalutati, e come è possibile favorire una maggiore consapevolezza nella comunità universitaria e nella società in generale?
I campanelli d'allarme del disagio psichico giovanile sono quelli che di frequente vengono erroneamente etichettati come difetti caratteriali o semplice incapacità di gestire la complessità della vita quotidiana.
Tra i segnali più sottovalutati vi è una profonda stanchezza mentale, spesso scambiata per semplice svogliatezza, che si manifesta con difficoltà di concentrazione e con l’incapacità di portare a termine anche i compiti più semplici. Un altro segnale chiave può essere la procrastinazione estrema, che non va sempre intesa come cattiva gestione del tempo ma, in alcune circostanze, come un meccanismo di difesa contro l'ansia da prestazione e la paralizzante paura di fallire.
Vanno inoltre monitorati i sottili cambiamenti somatici e comportamentali, come l'alterazione del ciclo sonno-veglia e le disfunzioni alimentari, che sono spesso i primi indicatori di ansia e depressione, anziché semplici cattive abitudini.
Per favorire una maggiore consapevolezza, è essenziale un cambiamento culturale: la comunità universitaria deve, oltre a istituire servizi per la salute mentale dedicati agli studenti e facilmente accessibili, promuovere l'educazione emotiva per de-stigmatizzare la richiesta di aiuto e promuovere connessioni sociali sane. È necessario riconoscere che il benessere psichico è un prerequisito per la performance e insegnare ai giovani che il loro valore non è definito esclusivamente dai risultati accademici o professionali.
Dottoressa Riboldi, qual è il ruolo di un’università come Bicocca nel promuovere non solo la ricerca scientifica, ma anche spazi di confronto e iniziative che aiutino a ridurre lo stigma legato ai disturbi psichici?
In questo scenario, un ateneo come Bicocca ha una responsabilità cruciale su due fronti complementari: da un lato, produrre e diffondere ricerca di alto livello sulla salute mentale giovanile, che permetta di identificare fattori di rischio e strategie d’intervento efficaci. Proprio questo è lo scopo della raccolta dati che stiamo conducendo con il nostro gruppo di ricerca nella popolazione universitaria.
In modo forse ancora più determinante, l’università deve fungere da laboratorio sociale per ridurre lo stigma che circonda i disturbi psichici. Tale obiettivo si realizza attraverso la creazione di spazi di confronto autentici e peer-to-peer, dove gli studenti possano parlare apertamente delle proprie fragilità senza temere il giudizio o ripercussioni sulla carriera accademica.
Iniziative come sportelli di ascolto, workshop sulla gestione dello stress e la consapevolezza emotiva, e campagne informative che utilizzino un linguaggio non clinico e accessibile sono essenziali. L'obiettivo primario è normalizzare la richiesta di aiuto e integrare il concetto di benessere psichico come parte integrante del successo formativo. Quando l'università riconosce e affronta apertamente il disagio, invia un messaggio potente all'intera società: la salute mentale è una priorità, e prendersene cura è un atto di forza e non di debolezza. In questo modo, l'istituzione non solo supporta i suoi studenti, ma si posiziona come catalizzatore di un cambiamento culturale più ampio.
L’evento Non sono solo Sénsazioni sarà un percorso dedicato alla scoperta della Costruzione del Sé, un’occasione per riflettere, confrontarsi e lasciarsi ispirare da nuove prospettive.
Aperto al pubblico, ad ingresso gratuito, si svolgerà venerdì 10 ottobre dalle 14:00 alle 17:00 presso l’Auditorium del Bicocca Pavilion. I posti sono limitati quindi è richiesta l’iscrizione tramite il seguente link Registrazione evento "Sénsazioni". Il programma completo dell’evento è disponibile qui .